Di Massimo Acciai Baggiani
 Isaac Asimov (1920-1992) è e rimarrà per sempre un mito per me, un vero gigante della fantascienza, tuttavia alcuni suoi libri, per sua stessa ammissione, risentono in misura maggiore o minore dell’obsolescenza a cui questo genere narrativo è condannato dal continuo avanzare della conoscenza scientifica. Questo nulla toglie alla godibilità dei suoi romanzi e racconti, ambientati in un futuro remoto: un buon intreccio e una buona narrazione rimangono tali anche se vengono superati i presupposti astronomici. Di Asimov ho letto buona parte della sua sterminata produzione, dalla narrativa alla saggistica; mi mancava il ciclo di Lucky Starr. Ho colmato di recente questa lacuna; la lettura dei sei romanzi che compongono la saga, scritti tutti negli anni Cinquanta e ambientati in un futuro distante migliaia di anni, mi ha suscitato diverse riflessioni.
Isaac Asimov (1920-1992) è e rimarrà per sempre un mito per me, un vero gigante della fantascienza, tuttavia alcuni suoi libri, per sua stessa ammissione, risentono in misura maggiore o minore dell’obsolescenza a cui questo genere narrativo è condannato dal continuo avanzare della conoscenza scientifica. Questo nulla toglie alla godibilità dei suoi romanzi e racconti, ambientati in un futuro remoto: un buon intreccio e una buona narrazione rimangono tali anche se vengono superati i presupposti astronomici. Di Asimov ho letto buona parte della sua sterminata produzione, dalla narrativa alla saggistica; mi mancava il ciclo di Lucky Starr. Ho colmato di recente questa lacuna; la lettura dei sei romanzi che compongono la saga, scritti tutti negli anni Cinquanta e ambientati in un futuro distante migliaia di anni, mi ha suscitato diverse riflessioni.
Vediamo innanzitutto di cosa si tratta. Lucky Starr è un giovane agente del Consiglio delle Scienze, una potente organizzazione governativa la cui giurisdizione si estende sull’intero sistema solare: il suo vero nome è David, il soprannome Lucky (“fortunato”) gli viene dal fatto che riesce a cavarsela brillantemente in ogni situazione grazie anche all’aiuto della sua buona stella (giusto per rimanere in tema spaziale) oltre che alla sua intelligenza e coraggio, e dall’aiuto dei suoi amici. Ciascuno dei sei romanzi che lo vedono protagonista è ambientato in un luogo specifico del Sistema – nell’ordine: Marte, la Cintura degli Asteroidi, Venere, Mercurio, le lune di Giove e gli anelli di Saturno – colonizzato da secoli dai terrestri (diventati poi marziani, venusiani, eccetera), tranne Saturno (lì c’è una storia a parte, narrata nell’ultimo romanzo).
Le vicende del nostro Consigliere rientrano a pieno titolo nella fantascienza d’azione, ma con contaminazioni di spionaggio e giallo. Lucky è in pratica una sorta di 007 futuribile, che lavora per il suo pianeta, la Terra, contro il cattivo di turno – quasi sempre legato ai perfidi Siriani (in questo universo narrativo l’Umanità ha scoperto il salto nell’iperspazio e ha colonizzato vari esopianeti nella Galassia), o ai Siriani stessi (che fanno la loro comparsa di persona alla fine del ciclo). Sua spalla, amico e collaboratore è il nano Bigman (nome ironico ovviamente), marziano, con cui stringe un sodalizio nel primo romanzo per portarlo avanti per tutta la serie.
Lasciando da parte le vicende spionistiche (pure interessanti) e le descrizioni (non più attuali) dei vari pianeti, mi interessa qui analizzare l’immagine asimoviana del futuro. Lo trovo contraddittorio: da una parte si parla di un mondo altamente tecnologico, basato sulla scienza e il razionalismo, con invenzioni strabilianti e un universo le cui distanze astronomiche sono ridotte enormemente da astronavi in grado di viaggiare più veloci della luce, che al tempo stesso sono alla portata economica di tutti o quasi; dall’altra parte è un mondo culturalmente primitivo, al livello di western. I personaggi appaiono ben poco civili, sempre pronti a menar le mani e a buttarsi in scazzottate che sono fuori luogo perfino nel nostro presente; gli uomini (siano Terrestri, Marziani, Venusiani, Siriani eccetera) sono rimasti bellicosi come durante la Guerra Fredda e i politici non sono migliori di quelli del passato. Solo i robot, paradossalmente, sono più evoluti degli uomini, in quanto impediti dalle tre famose leggi della robotica a ricorrere alla violenza e all’inganno. Non c’è stato insomma alcun progresso dal punto di vista morale, tranne un sottinteso ateismo, e continua a valere quanto notato da Salvatore Quasimodo nella sua poesia Uomo del mio tempo. Ottimista sotto molti aspetti, in questo Asimov è pessimista: la sua visione storica è statica dal punto di vista della psiche umana: non importa quale sia il livello tecnologico raggiunto, gli ideali rivoluzionari di libertà, fraternità e uguaglianza rimarranno sempre irraggiungibili. Addirittura si avrà un’involuzione in un futuro ancora più remoto: l’intera Galassia sarà sotto un Imperatore![1]
La vita umana non sarà sacra e inviolabile nemmeno tra trentamila anni (questo pare il limite, se non erro, a cui si spinge il Ciclo della Fondazione), e ciò rende possibile le profezie di Hari Seldon tramite la sua Psicostoria. Questa è l’unica cosa che non condivido del grande scrittore americano: per come la vedo io (e non solo io) l’uomo è arrivato a un bivio; se non muterà di paradigma, se continuerà con la solita visione nazionalista e violenta, andrà incontro a un’estinzione sicura entro questo secolo, altro che trentamila anni! La visione politica di Asimov non è sostenibile in un’ottica di futuro remoto, l’uomo potrebbe distruggere questo pianeta ben prima di poterne colonizzare altri. Ma questo non era prevedibile, credo, settanta anni fa, quando Asimov ha creato questo ciclo…
Concludo con una nota che da esperantista e linguista mi ha colpito: Asimov non fa mai menzione in questo ciclo di quali lingue parlino i vari personaggi, lasciando supporre che si tratti dell’inglese o di qualche sua evoluzione, tranne appunto nell’ultimo libro del ciclo, Lucky Starr e gli anelli di Saturno, trattando di una conferenza interstellare: «I discorsi, com’era uso in questi incontri interstellari, si svolgevano in interlingua, l’amalgama di lingue che era usato in tutta la galassia»[2]. Non ho potuto fare a meno di domandarmi come potrebbe essere questa “interlingua”, frutto dell’incontro di lingue parlate migliaia di anni nel futuro (non troppo lontane dall’inglese, visti i nomi dei personaggi), ma di certo non è l’omonima Interlingua sviluppata dall’International Auxiliary Language Association (IALA) né tanto meno dell’Esperanto, il quale si basa su principi di pacifismo e fratellanza tra i popoli del tutto assenti nel ciclo di Lucky Starr.
Firenze, 27 luglio 2020
Bibliografia
Asimov I., Tutto Asimov Space Ranger, Firenze, Giunti Marzocco, 1978.
Note
[1] Si veda appunto il Ciclo dell’Impero e quello della Fondazione.
[2] Asimov I., Tutto Asimov Space Ranger. Robot, Firenze, Giunti Marzocco, 1978, p. 116. Per quanto riguarda le altre opere asimoviane, mi viene fatto notare da un membro di un gruppo FB di fantascienza, la lingua parlata nella Galassia questa è il Galattico, ma viene chiamata con nomi diversi nei vari romanzi, anche questa è una conseguenza del fatto che sono stati scritti nell’arco di un quarantennio. In Abissi d’acciaio, primo libro del Ciclo dei Robot, il protagonista Elijah Baley dice che la lingua parlata sulla Terra è l’Inglese e che, con lievi differenze, era usato anche nei mondi Spaziali. In I Robot dell’Alba, ambientato temporalmente una decina di anni dopo Abissi d’acciaio, Asimov usa l’espressione “Interstellare” per definire la lingua parlata nella Galassia. Infine ne I Robot e l’Impero, ambientato 200 anni dopo I Robot dell’Alba, compare per la prima volta l’espressione Galattico. Ci sono riferimenti all’Inglese anche in altri Romanzi Asimoviani. Ne Le Correnti dello Spazio, approssimativamente 4000/5000 anni dopo I Robot e l’Impero, si accenna ad un pianeta del Settore di Sirio, non ricordo quale ma non era la Terra, dove «il dialetto era tanto primitivo da poter quasi essere confuso con quella lingua leggendaria e, morta da millenni, che era l’Inglese». Infine in Paria dei Cieli, circa l’anno 12000 dc, si accenna ad iscrizioni trovate su Sirio, Arturo ed Alfa Centauri vecchie di 100.000 anni, e che erano state decifrate solo nell’ultimo decennio, iscrizioni che poi si scoprirà essere in Inglese.
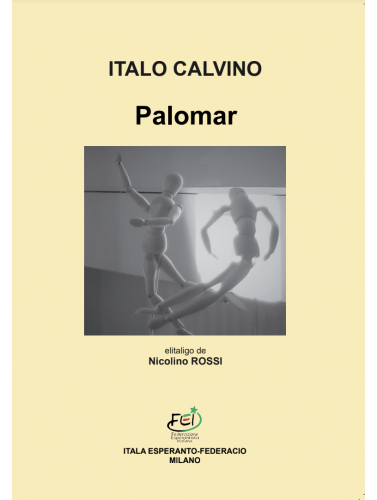










 Isaac Asimov (1920-1992) è e rimarrà per sempre un mito per me, un vero gigante della fantascienza, tuttavia alcuni suoi libri, per sua stessa ammissione, risentono in misura maggiore o minore dell’obsolescenza a cui questo genere narrativo è condannato dal continuo avanzare della conoscenza scientifica. Questo nulla toglie alla godibilità dei suoi romanzi e racconti, ambientati in un futuro remoto: un buon intreccio e una buona narrazione rimangono tali anche se vengono superati i presupposti astronomici. Di Asimov ho letto buona parte della sua sterminata produzione, dalla narrativa alla saggistica; mi mancava il ciclo di Lucky Starr. Ho colmato di recente questa lacuna; la lettura dei sei romanzi che compongono la saga, scritti tutti negli anni Cinquanta e ambientati in un futuro distante migliaia di anni, mi ha suscitato diverse riflessioni.
Isaac Asimov (1920-1992) è e rimarrà per sempre un mito per me, un vero gigante della fantascienza, tuttavia alcuni suoi libri, per sua stessa ammissione, risentono in misura maggiore o minore dell’obsolescenza a cui questo genere narrativo è condannato dal continuo avanzare della conoscenza scientifica. Questo nulla toglie alla godibilità dei suoi romanzi e racconti, ambientati in un futuro remoto: un buon intreccio e una buona narrazione rimangono tali anche se vengono superati i presupposti astronomici. Di Asimov ho letto buona parte della sua sterminata produzione, dalla narrativa alla saggistica; mi mancava il ciclo di Lucky Starr. Ho colmato di recente questa lacuna; la lettura dei sei romanzi che compongono la saga, scritti tutti negli anni Cinquanta e ambientati in un futuro distante migliaia di anni, mi ha suscitato diverse riflessioni.